La scienza è ricerca della verità.
Karl Popper
Ma la verità non è verità certa
Tutte le applicazioni della criminalistica sono utilizzate per la conduzione delle investigazioni e solo in minima parte sono poi introdotte e valutate nelle corti di giustizia, durante il processo. Non tutte dunque servono per la ricerca della verità processuale. Il che avviene secondo procedure che tengono conto da un lato della salvaguardia dell’interesse pubblico, dall’altro della tutela della libertà del cittadino. La percezione comune delle vicende investigative e giudiziarie è invece molto diversa. Chiunque può farsi un’opinione su di un fatto, anche un episodio di natura giudiziaria, leggendo i giornali, ascoltando i notiziari, o trovando in rete una moltitudine di dati aperti riguardo a circostanze, eventi, che nel loro insieme danno un’idea molto marginale di ciò che è davvero accaduto in un episodio. Neanche l’enorme diffusione di telecamere di controllo che ormai dovunque tracciano gli spostamenti di noi tutti, può sempre fornire certezze.
Ma più o meno tutti amiamo improvvisarsi investigatori o giudici, e magari pensiamo anche di fornire giudizi attendibili, più o meno come ciascuno di noi si ritiene il miglior allenatore della nazionale di calcio. Avvezzi a una comunicazione rapida e a ricevere un costante afflusso di informazioni in tempo reale da svariate fonti, facilmente disponibili e alla portata di tutti, subentra la convinzione che interpretare i fatti giudiziari sia un lavoro semplice. Suggestione certamente enfatizzata dal gran successo delle fiction in tema criminologico, nelle quali la drammaticità delle situazioni è quasi sempre riequilibrata dall’individuazione del colpevole, assicurato alle patrie galere nel giro di pochi giorni. E dunque anche il concetto comune di prova è certamente reso semplice.
«Ma come, lo hanno trovato con l’arma del delitto ed è ancora libero?»; «Dicono che abbiano trovato il DNA della vittima sui suoi abiti e non lo condannano?». Molte volte mi sono state chieste opinioni, in quanto «esperto», su fatti di cronaca che avevano riempito pagine dei giornali e trasmissioni televisive. I miei tentativi di far presente che non sapevo niente della vicenda, sistematicamente sono passati come tentativi di eccessiva riservatezza o falsa modestia. In realtà non conoscevo semplicemente i fatti!
Se ci pensiamo bene, in definitiva, l’idea che abbiamo di prova è semplicemente di un qualcosa che avvalora le nostre ipotesi. E’ una percezione spesso inconsapevolmente precostituita, che ci permette di placare il profondo senso di ingiustizia. Che avvertiamo di fronte a episodi contrari alla natura dell’uomo; comportamenti umani che influenzano un po’ tutti noi. Certamente, però, questo concetto di prova è molto distante dal significato reale nell’ambito processuale. Aggiungerei: «per fortuna!». Immaginate se un giudice condannasse in base alle proprie sensazioni o alla simpatia o antipatia verso l’imputato!
Anzi, il «bravo giudice» è proprio colui che non si fa guidare dalle sensazioni. Si deve limitare ad applicare con freddezza la legge, comprese le norme sull’istruzione probatoria e sulla valutazione delle prove stesse.
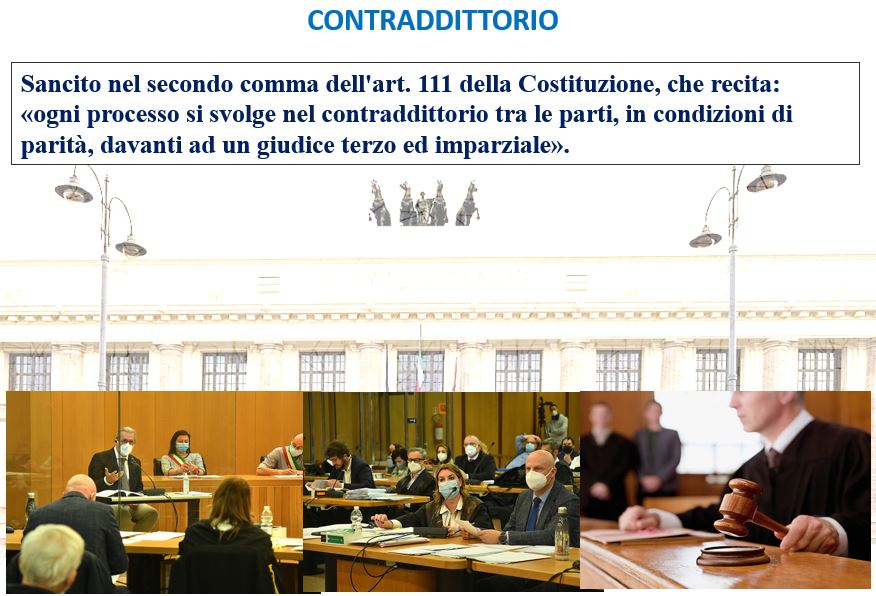
Non certamente quello che condannasse perché convinto, a prescindere dalle prove, della colpevolezza dell’imputato, magari sulla base del curriculum dei precedenti penali.
La ricostruzione per la verità processuale
Nel processo dovrebbe effettivamente avvenire il tentativo della ricostruzione di un accadimento e il giudice si trova quindi a indossare anche le vesti dello storico. Così avviene la ricerca della verità processuale. I fatti sono oggetto di enunciati ipotetici, ossia di proposizioni la cui verità o falsità è incerta. E anche l’oggetto del giudizio sarà dunque costituito da un insieme di enunciati ipotetici. Relativi a tutti i fatti principali e secondari che siano rilevanti ai fini della decisione del caso.
Ma il giudice ha a che fare anche con la scienza. Specialmente con gli apporti della criminalistica che forniscono un aiuto per la comprensione del fatto storico. Vi sono però differenze sostanziali tra il concetto di verità accolto in campo scientifico e quello in campo storico-giuridico. Nel primo caso la verità si ritiene raggiunta quando l’ipotesi corrisponde alla misurazione effettiva del fenomeno osservato. E a questo proposito lo scienziato può ripetere i propri esperimenti, anzi deve farlo, per confermarne la validità.
Il giudice deve, invece, valutare un episodio del passato, quindi già trascorso e dunque irripetibile. Per lo storico e per il giudice, la verità si ritiene raggiunta quando l’ipotesi sull’esistenza di un fatto corrisponde alla ricostruzione del fatto stesso, ottenuta mediante prove.
