La misura della nostra libertà esistenziale dipende sia dal nostro sistema politico sia dalla vigilanza come difensori delle sue libertà. La durata della nostra vita dipende sia dai nostri geni sia dalle attenzioni per la nostra salute.
Lou Marinoff
E la qualità della nostra vita – la capacità di essere riflessivi, di comportarci rettamente e virtuosamente, di essere allegri, di saper amare – dipende sia dalla nostra filosofia, sia dal modo con cui la applichiamo a ogni cosa. La vita esaminata è una vita migliore, ed è alla tua portata!
La ricerca della verità attraverso una macchina o un metodo in grado di fornire dati oggettivi per la ricostruzione storica dei fatti, permettendo quindi di essere certi di non sbagliare nell’infliggere condanne, è un bisogno che ciclicamente si ripresenta al sorgere di innovazioni tecnologiche.
Lo è stato con la macchina della verità e lo è stato con i test del DNA.
La presenza capillare di decine di laboratori in tutto il mondo e l’esistenza di Banche dati forensi dimostra che questa materia è certamente la vera rivoluzione della criminalistica.

I test del DNA certamente funzionano, anche se non sono la sfera di cristallo del veggente. Ci sono infatti dei limiti tecnico-scientifici nell’analisi biologica. L’impossibilità di capire con assoluta certezza da che parte del corpo derivi una traccia, l’impossibilità di datare i reperti, la tendenza alla degradazione. Argomenti sui quali i ricercatori cercano di trovare delle soluzioni percorribili, per ottenere risultati sempre più affidabili.
Nel frattempo con l’attivazione della Banca dati forense italiana, la cui attesa era divenuta peraltro imbarazzante, non avviene soltanto un allineamento alle regolamentazioni europee, ma si attiva un virtuoso e inarrestabile meccanismo a catena che rappresenterà un beneficio per l’intero sistema giudiziario italiano. La consapevolezza che la prova scientifica debba essere qualificata sta diventando infatti una certezza per i giuristi e anche per l’opinione pubblica. Del resto perché non dovrebbe essere così?
Tutti i settori della criminalistica si stanno muovendo in questa direzione. E infatti già da qualche tempo si assiste alla promozione della qualità e al conseguimento delle certificazioni ISO da parte dei settori specialistici delle Forze dell’ordine, in ambiti come quello delicatissimo del sopralluogo giudiziario, della repertazione, delle impronte digitali, delle analisi degli stupefacenti. Si tratta di una vera e propria trasformazione culturale che pervade gli ambienti giudiziari, dando significato concreto al concetto di «prova scientifica», basata su misurazioni puntuali più che sensazioni, sul calcolo dell’incertezza più che sull’esperienza, sulla tracciabilità più che sulla memoria[1].
Dal punto di vista tecnico, così come avvenne quando fu attivato il sistema AFIS per le impronte digitali, dal momento in cui tutti i profili genetici acquisiti dalle varie Forze di polizia confluiranno nella Banca dati, i riscontri immediati probabilmente consentiranno, in tempo reale, l’identificazione di molti «sconosciuti» e di conseguenza la risoluzione di casi giudiziari per i quali si cerca ancora un colpevole. È probabile che si tratterà di casi minori, quelli che non ci vengono proposti la sera in televisione e trovano spazi marginali nella cronaca nera, non interessando gli scrittori di noir.
Quelli, però, che interessano, e molto, chi ha patito una violenza, un sopruso, un danno al patrimonio. Intendiamoci, non che gli investigatori non siano interessati a questo tipo di reati, sia ben chiaro, ma davvero non hanno il tempo materiale per seguire l’enormità di reati giornalieri che avvengono sul territorio, in numero elevatissimo secondo quello che ci ricordano le statistiche, più di 5 al minuto. Necessariamente ci si concentra su quelli più gravi, in relazione alle forze disponibili.
Furti, piccole rapine, lesioni, risse, sono tutti delitti nei quali è frequente rinvenire tracce biologiche, delle vittime e degli autori che spesso lasciano i segni delle loro scorribande criminali. Poter produrre profili genetici da questa plètora di reperti emettendo dei «rapporti di prova» secondo la norma ISO/IEC 17025, come prescrive la legge, significa dare in mano agli investigatori uno strumento reale per risolvere quell’indagine. Quel documento è lo strumento con cui la polizia giudiziaria potrà interrogare la Banca dati del DNA, chiedendo riscontri che avverranno in poche ore: il tempo di inserire i dati su un terminale e attendere una comparazione attraverso il sistema elettronico. «Nella matassa incolore della vita scorre il filo scarlatto del delitto.
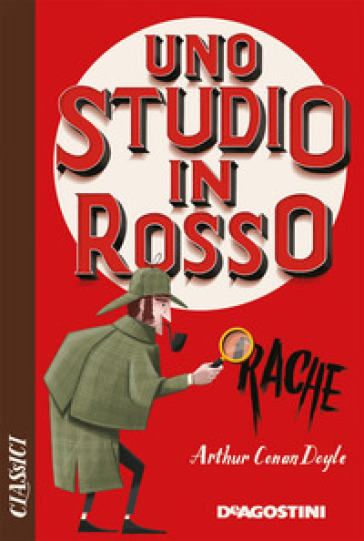
Noi abbiamo il dovere di dipanarlo, isolarlo e tirarlo fuori da capo a fondo», dice Sherlock Holmes in Uno studio in rosso. Questo straordinario e indispensabile strumento può davvero indirizzare l’inchiesta nella direzione giusta, fornendo quei riscontri oggettivi che aiutano a comprendere le dinamiche dei fatti.
Si tratta di un tassello nell’intreccio del delitto, al pari di altre fondamentali attività tradizionali, come le testimonianze, le intercettazioni telefoniche o altre proprie della criminalistica. C’è poi l’intuizione dell’investigatore che pare essere stata appannata, anziché stimolata, dall’introduzione delle nuove tecnologie, e che resta invece fondamentale per la risoluzione del delitto: il DNA non può spiegare tutto. Occorre magari una maggiore preparazione da parte di coloro che svolgono le indagini, che dovrebbero essere in grado di conoscere le informazioni che il laboratorio può davvero esaudire, applicando le conoscenze alla realtà dei sopralluoghi, specialmente per comprendere le eventuali dinamiche e le modalità di trasferimento della traccia.
Qualche volta abbiamo ospitato in laboratorio magistrati in formazione e personale della polizia giudiziaria, dotandoli di camice e guanti per poi far loro provare alcune delle tecniche basilari del laboratorio. Leggo ancora lo stupore nei loro occhi nel constatare le piccole quantità con cui lavoriamo, l’imbarazzo di indossare e lavorare con i sistemi di protezione individuali; una prospettiva diversa che aiuta però a comprendere. Investigatori più preparati nel conoscere le potenzialità delle tecniche disponibili e delle quali potranno avvantaggiarsi ottenendo indizi utili: ecco che cosa può essere davvero utile. Fare delle domande corrette, e sapere che cosa chiedere, è fondamentale per ottenere risposte appropriate.
L’utilità sociale di un servizio di genetica forense sul territorio oggi mi pare quindi indubbia. Il modello approntato sulla base del «Progetto forense toscano» ha finora funzionato, come testimonia il lavoro di questi anni e il riconoscimento e la visibilità che sono stati dati in più occasioni, dagli organi investigativi e dalla magistratura. Nello sviluppo futuro occorrono però un contesto e un ambiente appropriati, perché le sfide divengono più ardite e il livello qualitativo ha avuto un’impennata al rialzo, come è giusto che sia.
Il contesto è necessariamente quello dell’appropriatezza dell’attività che ci si appresta a consolidare, attraverso la condivisione degli obiettivi con l’alta dirigenza. Più di un collega da diversi istituti italiani mi ha contattato per avere informazioni sull’iter da intraprendere per conseguire l’accreditamento ISO/IEC 17025. Tutti confidano sul fatto che sarei stato in grado di fornire un aiuto in questo senso, forte delle competenze acquisite con ACCREDIA.
Il passo indispensabile per l’attivazione di un laboratorio accreditato non è però un fatto tecnico, né economico. E’ una scelta dell’alta direzione che «deve fornire evidenza dell’impegno a sviluppare e attuare il sistema di gestione e a migliorare in modo continuo l’efficacia dello stesso». Secondo il dettato della norma ISO/IEC 17025 (punto 4.2.3). Se manca questa volontà non si va da nessuna parte; oltre alle buone idee servono sempre gli strumenti (anche economici certamente), per realizzarle. Ne ho parlato nel dettaglio nell’ultimo libro “Profili di Qualità”. È poi necessaria la volontà del personale di accettare le sfide e soprattutto i cambiamenti: «La maggior parte delle persone si tira indietro di fronte al cambiamento. Non lo ama, perché cambiare significa fare un passo in un terreno inesplorato» (Neale Donald Walsch).
Riferendomi al contesto locale, la progettualità della Regione Toscana sembra aver tracciato una linea d’intenzione nell’aver firmato un atto di convenzione con la Procura generale della Toscana. Certo, la «prestazione forense» non è di natura diagnostica, a meno che non si voglia individuarla così, ma sarebbe davvero una grande novità inserire, per esempio, un test di paternità e familiarità tra le prestazioni a cui sia riconosciuto un valore sociale, per il quale il sistema sanitario sia disposto a contribuire.
Riguardo all’ambiente appropriato, è oggi anche necessario individuare dotazioni strutturali e strumentali particolari per condurre esami di così alto profilo. Si è passati da un momento in cui sembrava semplice fare analisi del DNA, dotandosi del minimo necessario, a oggi in cui queste attività si possono effettuare solo in ambienti idonei. Questi devono essere dedicati e con strumentazioni di alta tecnologia.
Il compromesso non è più, giustamente, tollerabile. Occorrono ambienti protetti, non condivisi con le altre funzioni di un laboratorio di diagnostica tradizionale. Compresi spazi ampi per l’esame dei reperti, con la possibilità di accessi ai consulenti che possano visionare, anche senza accedere ai locali, le operazioni effettuate dai consulenti incaricati.
La grande quantità dei reperti che affluiscono a un laboratorio forense richiede inoltre dei locali idonei alla custodia in sicurezza, con frigoriferi e banche biologiche in grado di conservare per lungo tempo reperti giudiziari ed estratti biologici. L’euristica dell’affetto, in questo caso nelle capacità del proprio laboratorio, quello che magari si è costruito con tanto sacrificio, espone alle cattive conseguenze di accertamenti fallimentari se non è possibile conseguire gli adeguamenti necessari.
Dunque, al di là dei progetti, bisogna valutare bene quelle che sono le risorse in campo. Per dar modo all’esperto forense di poter lavorare con serenità. Si tratta di una figura molto diversa da quella che si è abituati a vedere nei serial televisivi e che, se così si comportasse, nella realtà determinerebbe cortocircuiti pericolosi. Un conto sono le identificazioni biologiche, un altro le ricostruzioni causali delle dinamiche dei fatti e quelle storiche di un episodio criminale.
L’esperto forense non è però neanche un semplice analista. Chi pensa che fare un’analisi del DNA in ambito criminalistico equivalga a un qualsiasi esame di laboratorio, si sbaglia di grosso. Le sollecitazioni sono molteplici ed entrano in gioco fattori diversi, comprese euristiche comportamentali e trappole mentali, sconosciute a coloro che svolgono un’attività di laboratorio ordinaria, anche complessa.
Il pensiero veloce, proprio del Sistema 1, guida abitudini e intuizioni ricorrendo alle associazioni tra esperienze che ciascuno di noi ha vissuto o che ha visto vivere agli altri. Il pensiero lento, caratteristico del Sistema 2, si affida invece alla ragione ed è lì pronto a trattenere alla briglia il Sistema 1. Per evitargli di commettere sbagli. Quando entrambi si muovono in sintonia e in modo consapevole, possiamo permetterci di ottenere i migliori risultati da noi stessi. In tutto ciò che facciamo, raggiungendo uno stato di equilibrio e di vigilante attesa. Si tratta di applicare quell’autopsia cognitiva indispensabile che porta, attraverso il ragionamento metacognitivo, alla scelta delle strategie appropriate per condurre un accertamento forense.
In questo senso, utilizzare un metodo di prova interno validato, secondo le prescrizioni dell’accreditamento, offre vantaggi innegabili. Permette di esercitare un autocontrollo continuo del processo analitico, gestendo quindi anche quelle deviazioni dalla normalità. Gli sbagli sono autentiche occasioni per migliorare le performance, con spirito critico. «Gli errori, ovviamente, ci mostrano quello che ha bisogno di essere migliorato. Senza errori, come sapremmo su cosa dobbiamo lavorare?» (Peter McWilliams).
È poi necessario valorizzare le componenti qualitative nei rapporti lavorativi, sociali, relazionali, valoriali e affettivi. Si deve costruire un modello fondato sulla reale condivisione degli obiettivi strategici di breve e lungo termine. Il sapere e la conoscenza non sono imputabili a un individuo solitario. Debbono essere distribuiti in una dimensione sociale, psicologica e cognitiva ampia del gruppo.
La visione dell’esperto forense che lavora da solo è semplicemente falsa. Può capitare, certo, specialmente nelle piccole realtà, ma non può essere la regola. Basti pensare all’esame di un reperto forense, anche il più semplice. Già dagli esami preliminari, dove diverse fasi che si intrecciano sono necessarie. Quella documentale che richiede di descrivere le caratteristiche dell’oggetto, quella fotografica, quella del campionamento. Non parliamo poi quando si tratti di applicare accertamenti orientativi, come il luminol o le luci forensi. Quante volte dovrebbe cambiare i guanti l’operatore, se svolgesse da solo tutte queste operazioni? Come dovrebbe comportarsi con l’interruttore delle luci della stanza per le ispezioni, a ogni accensione/spegnimento? Come controllare le contaminazioni, in questi casi?
Occorre evidentemente un lavoro di équipe che coinvolga più figure, possibilmente intercambiabili, per la gestione complessiva del metodo di prova. Diverse linee guida e anche dal regolamento attuativo della Banca dati, lo suggeriscono. Per esempio laddove viene indicata la necessità che due operatori verifichino la genuinità di un profilo genetico, prima dell’inserimento.
Da questo punto di vista, il metodo di prova offre garanzie di risolvere attraverso la «via dell’algoritmo» quasi tutti i problemi relativi all’oggetto da esaminare. Occorre un’attiva strategia di ricerca di soluzioni accettabili per la gestione di un sano rapporto in ambito lavorativo, nella relazione con gli altri. È questo un argomento complesso, che sottende le logiche del comportamento umano. Richiede di attingere a quelle risorse, proprie dell’intelligenza emotiva, che non sono molto comuni, almeno nella mia esperienza.
Proprio nell’ambiente di lavoro, secondo me, si manifesta a più riprese e con maggiore evidenza l’importanza di un’intelligenza emotiva. Non solo una logica fredda e astratta, ma una combinazione armonica di diverse capacità. È chiaramente un «approccio euristico», come viene oggi definito, anche se a me lo hanno sempre insegnato semplicemente come buon senso. Implica una serie di qualità indispensabili come l’ottimismo, l’adattabilità e lo spirito di iniziativa. Certo doti innate ma che si possono apprendere e mettere in pratica. Come dicono i sacri testi di Daniel Goleman che ha affrontato nel dettaglio le caratteristiche emozionali del comportamento delle persone, anche nell’ambito lavorativo[2].
Occorre certo una grande sicurezza e capacità tecniche di alto livello per guidare un gruppo attraverso un comportamento basato su una strategia così incerta. Questo modo di arrivare alle decisioni genera sempre ansia e paure, soprattutto se i tempi per il raggiungimento degli obiettivi sono stretti. Oltre a competenze emotive reali indispensabili, come appunto il controllo dell’ansia e delle emozioni in genere, sono necessarie competenze sociali. Queste sono proprie di quell’intelligenza collettiva che facilita la comunicazione e il saper lavorare con gli altri.
Per ultimo, ancora due parole sulla scienza del crimine e sulla genetica forense. Taluni sostengono che la criminalistica non sia scienza autonoma, ma che attinga dalle altre discipline scientifiche per applicare i metodi al l’identificazione. Se forse un tempo è stato così, oggi credo le cose siano profondamente diverse per la maggior parte delle materie che studiano il crimine.
Certamente non lo è per la genetica forense, le cui peculiarità sono talmente profonde da richiedere ormai una qualificazione specifica di professionisti. Questi devono essere in grado di conoscere simultaneamente materie come biologia e genetica, diritto e procedura penale, informatica e calcolo statistico. Per questo ha un senso prevedere una maggiore formazione dei giovani sulle materie della criminalistica. E’ quindi atteso un risveglio d’interesse accademico soprattutto da parte degli istituti di medicina legale. Questi sono i punti di riferimento privilegiati, dell’ambiente del foro e di quello della ricerca, perché c’è ancora molto da scoprire.
La genetica forense ha determinato una svolta profonda in tutto il sistema delle indagini criminalistiche. Ha introdotto una vera e propria «cultura dello studio del crimine», come non si era mai vista in tutto il secolo scorso, per nessuna disciplina. Alcuni autori hanno sottolineato l’empirismo delle altre materie forensi[3]. In questo contesto le altre discipline della criminalistica devono ancora percorrere una lunga strada. Il test del DNA ha tracciato una via percorribile. Si tratta quindi di restare sulla carreggiata e non temere di andare avanti.
[1] U. Ricci, Un lampo di consapevolezza nella normativa italiana: il DNA oltre la suggestione e il mito, in Diritto penale e processo (2016)6.
[2] D. Goleman, Lavorare con intelligenza emotiva. Come inventare un nuovo rapporto con il lavoro, Rizzoli, Milano 2000; Id., Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 2013.
[3] R.D. Stoel et al., Building the research culture in the forensic sciences: Announcement of a double blind testing program, in Science and Justice (2016)56, 155-156.
