Effettivamente quando si parla di fallimento della prova scientifica, nell’ambito della giurisprudenza, si tocca una ferita scoperta. Nessun cataplasma e medicamento è mai riuscito a lenirle. Anzi, i conflitti tra diritto e scienza sembrano destinati a esacerbarsi sempre più. Lo dimostra la sentenza dell’ottobre 2012 del Tribunale dell’Aquila che condannò a sei anni i componenti della Commissione Grandi rischi per aver sottovalutato la possibilità di un sisma nel territorio abruzzese [1].
In tema di genetica forense esperti giuristi hanno più volte affrontato l’argomento. Certamente quando si esce dal settore specialistico resta lo stupore e la frustrazione. Anche da parte degli stessi investigatori, su come miseramente possano soccombere in dibattimento evidenze in un primo tempo presentate con valore perentorio. Così non è facile supportare l’accusa nei confronti di un indagato.
C’è una logica in base alla quale si dovrebbe cambiare parere alla luce delle prove. Le credenze precedenti vanno combinate con la diagnostica della criminalistica, ovvero con il grado in cui le evidenze favoriscono l’ipotesi rispetto all’alternativa. Eludere questo schema espone all’insidioso fenomeno noto come inferential bootstrapping che conduce a valutare le evidenze in modo improprio [2].
Questo avviene quando un esperto, avendo conoscenza del fatto che un altro elemento di prova nel caso dimostra la colpevolezza dell’indagato, risolve le ambiguità dell’analisi che sta effettuando in un modo tale da confermare l’evidenza ottenuta anche sull’altro elemento di prova.
Si rileva un’impronta digitale nel sopralluogo con 10-11 punti d’identità con il sospetto e, per lo stesso episodio, si è determinato un profilo genetico della stessa persona, su un altro elemento di prova, con un profilo parziale compatibile per 5-6 marcatori. La tendenza è dunque quella di individuare elementi aggiuntivi, in questo caso per la prova dattiloscopica (qualche altro punto di utilità), per quella genetica (un marcatore i cui risultati erano incerti), in modo che i confronti di entrambi confermino l’identificazione.
Un altro fenomeno interessante è noto come «l’errore del tiratore scelto texano» (Texas sharpshooter fallacy) [3].
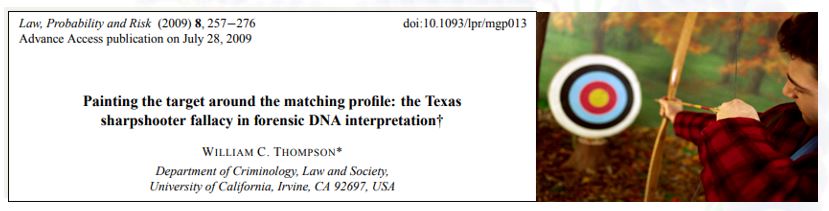
Questo è il nome che gli epidemiologi hanno dato alla tendenza ad assegnare significati errati a dati sperimentali visionandoli a posteriori, in un ingiustificato contesto ristretto[4]. Il termine deriva dalla storia di un leggendario texano il quale sparava a caso con il proprio fucile sulla facciata di una stalla. Poi dipingeva un bersaglio intorno a ciascun foro di proiettile. Quando la vernice era asciutta invitava i vicini per mostrare loro la propria abilità, destando grande stupore. Ogni colpo un centro. Naturalmente si trattava di un inganno, perché il tiratore creava il bersaglio dopo aver sparato. Questo tipo di comportamento viene anche chiamato «disegnare il bersaglio intorno alla freccia» (painting the target around the arrow). E’ molto più comune di quanto si creda in tutti i settori delle analisi criminalistiche, genetica forense compresa.
Nella verifica a posteriori degli errori commessi dagli analisti coinvolti negli scandali statunitensi mostravano la tendenza a comportarsi come il tiratore scelto. Viene attivata un’euristica semplice, rinunciando alle interpretazioni più fini che richiedevano uno sforzo cognitivo che gli esperti non ritenevano necessario. In qualche maniera, gli analisti sceglievaùno la strada più facile. Partivano dalla convinzione di un risultato e poi, modificando i criteri di valutazione dell’evidenza, adattavano i risultati. Finché questi confortassero le aspettative preconcette.
L’autore è docente di Criminologia, legge e società all’Università della California-Irvine. Egli giustifica questi errati modi di valutare l’evidenza alla forte pressione psicologica a cui sono sottoposti gli esperti. Quest’ultimi debbono spesso esaminare rapidamente dati raccolti durante cruenti episodi criminali. È ovvio che l’analista non dovrebbe subire alcuna influenza. Soprattutto se lo distrae dalla descrizione pura e semplice di quando è sul bancone del proprio laboratorio. E dunque dall’applicazione, rigida, del proprio metodo validato.
Il problema è che, se non stiamo molto attenti, il nostro comportamento è guidato da atteggiamenti che sfuggono al nostro controllo mentale.
[1] Sentenza-sul-sisma-d-abruzzo-cosi-gli-scienziati-non-daranno-piu-pareri. La Stampa22-10-2012.
[2] https://learningds.org/ch/17/inf_pred_gen_boot.html
[3] W.C. Thompson, Painting the target around the matching profile: The Texas sharpshooter fallacy in forensic DNA interpretation, in Law, Probability and Risk (2009)8, 257-276.
[4] A. Gawande, The cancer-cluster myth, in The New Yorker, Feb 8, (1999), 34-37.
