Il crimine è una cosa comune. La logica è rara. Tuttavia è sulla logica che si dovrebbe insistere.
Arthur Conan Doyle
Uno dei più assillanti bisogni dell’uomo è sempre stato quello di comprendere l’ignoto che lo circonda, cercando di dominare una natura misteriosa e, talvolta, pericolosa.

Un inesauribile desiderio che ha trovato nel genio di inventori e scienziati la dimostrazione che esistono delle espressioni della natura in grado di spiegare fatti, per la risoluzione dei quali i nostri antenati si rivolgevano, invece, agli oracoli.
Ma qual è la storia della criminalistica?
Un esempio è quello del tema della filiazione. L’antropologia ci insegna che una delle più antiche paure dell’uomo è quella di allevare figli non suoi. La natura ha così adottato un piccolo trucco in modo da aiutare i figli a essere accettati e protetti ed è per questo che nel primo anno di vita i figli assomigliano molto al loro padre biologico, come riporta la studiosa Alexandra Alvergne, antropologa dell’Istituto di scienze evolutive di Montpellier [1].
Per far dormire sonni tranquilli ai nostri predecessori non era sufficiente però l’intuizione che lasciava spalancata una breccia incolmabile a valutazioni empiriche. Erano quindi sempre ben accolte le novità della scienza che sembravano dare certezza, attraverso un metodo obiettivo finalmente risolutivo, per comprendere i misteri, accertare le paternità, scoprire i criminali e le truffe. La storia della criminalistica si allunga nel corso dei secoli.
Tuttavia già da allora non erano rari i tentativi di mistificazione, come racconta una storia del VI secolo a.C. Un marito, volendo divorziare dalla moglie, approfittò di una festa in cui la fece ubriacare. Poi la distese su un sofà insieme a un ospite, anch’esso ubriaco, e versò tra i due dell’albume d’uovo. Intendeva così mostrare questa traccia come evidente prova dell’adulterio. La vicenda si concluse con la scaltrezza della donna la quale chiamò il proprio medico che identificò la sostanza come chiara d’uovo e non come liquido seminale. Non è dato sapere come abbia fatto, né se furono richieste controanalisi, né come ebbe termine la vicenda [2].
La ricerca di metodi scientifici, che oggi sono uniti nella disciplina definita criminalistica, ha interessato praticamente tutti gli ambienti. Si è evoluta in modo talvolta caotico e casuale, con intrecci tra discipline diverse e apparentemente lontane, accomunate dal desiderio della risoluzione del crimine, dell’identificazione del delinquente e del suo allontanamento dalla comunità, per l’eliminazione del pericolo rappresentato dalla possibile reiterazione del fatto criminoso.
Forse una delle migliori definizioni viene da Mantovani che nel 1979 definì la criminalistica come:
quella particolare tecnica dell’investigazione criminale che studia il complesso dei mezzi, suggeriti dalle varie scienze, per l’accertamento del reato e la scoperta dell’autore ed alla quale appartiene una massa di nozioni di medicina legale, di dattiloscopia, di antropometria, di balistica giudiziaria, di grafometria, di tossicologia forense… In essa, dunque, confluiscono scienze e discipline, autonome ed indipendenti l’una dall’altra, con un comune oggetto di indagine rappresentato dalla scoperta del reato, dell’autore e spesso anche dall’individuazione della vittima.
È interessante ripercorrere attraverso alcune delle tappe più significative registrate nel corso del tempo, l’evoluzione di questa disciplina, a indicare la nascita delle varie specialità, segnate dalla pubblicazione di opere letterarie ancora oggi attuali e che in alcuni casi hanno portato all’affermarsi di istituzioni prestigiose, oggi ben strutturate.
A fronte di queste tappe significative, per molti secoli vi è stata invece una sovrapposizione tra mezzi d’indagine. Strumenti di riconoscimento del reo, misure punitive, miti, superstizioni, riti. La commistione tra reato e peccato e l’uso di mezzi empirici per l’identificazione (testimonianze oculari, processi sommari, ordalie, torture, denunce segrete) produceva un senso d’ingiustizia generalizzato riguardo all’identificazione e l’indagine a fini di giustizia dava spesso origine a grossolani errori.
Le prime prospettive scientifiche di identificazione forense, intuitive e pratiche, emersero solo dalla seconda metà dell’Ottocento. Era un periodo di risveglio della criminologia, per esempio con l’opera L’uomo delinquente di Cesare Lombroso. Con la scuola positiva, le teorie del determinismo biologico del Lombroso e i concetti di eredità darwiniana si affermarono le teorie dei primi tre «investigatori forensi» della storia. Alphonse Bertillon, curatore del segnalamento giudiziario antropometrico. Francis Galton, cugino di Charles Darwin, considerato l’ideatore della dattiloscopia. Salvatore Ottolenghi, inventore del sopralluogo di polizia giudiziaria.
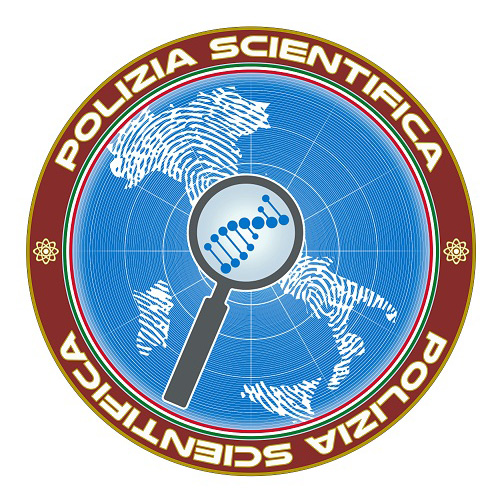
A Salvatore Ottolenghi si deve la nascita della scuola di polizia scientifica. A somiglianza di quella francese fondata da Bertillon, si assunse il compito di formare investigatori preparati con opportuni tecnicismi. Specialmente nel settore del sopralluogo, con l’intento finale dell’individuazione del criminale.
Così, le tecniche d’identificazione si fondevano con quelle più propriamente rivolte alla caratterizzazione della psicologia criminale. La prima suddivisione dell’istituto di polizia scientifica prevedeva, affiancato al servizio centrale di segnalamento e identificazione, quello antro-psicologico-biografico [3]. Negli anni seguenti vi fu un progressivo affinamento delle tecniche con il tentativo di costruire teorie generali.
Volendo effettuare una ricognizione, si possono individuare alcuni concetti fondamentali che forniscono una struttura filosofica e razionale generale per tutte le applicazioni della conoscenza scientifica criminalistica, nell’arena forense. Ne ho scritto molte volte nei miei articoli, citati qui, e nei miei libri, che troverete qui. Tali enunciati guidano l’analisi forense in una progressione logica iniziando dalla descrizione della fonte di prova e culminando in un giudizio riguardo al significato di un risultato analitico. Anche se evoluti in un modo disordinato, se ne può trovare una sintesi in un articolo del dipartimento di giustizia della California. Qui c’è la descrizione dei concetti di trasferimento, identificazione, individualizzazione, associazione e ricostruzione, con ulteriori approfondimenti riguardo al concetto di materia divisibile [4].
[1] A. Alvergne et al., Father-offspring resemblance predicts paternal investment in humans, in Animal Behaviour (2009)78, 61-69.
[2] H.W. Smith, Scientific Proof, in Southern California Law Review (1948)16, 148. L’autore riporta che a quel tempo avrebbero usato il metodo di Florence per condurre l’accertamento, che consiste nel mettere a contatto la traccia con una soluzione di iodio e osservare in microscopia il risultato. In presenza di liquido seminale si osserva la formazione di un bellissimo precipitato di cristalli di perioduro di colina, sostanza presente in questo fluido biologico.
[3] R. Paceri, Indagini tecniche e documentazione, Tipografia Scuola Superiore di Polizia, Roma 1973.
[4] K. Inman – N. Rudin, The origin of evidence, in Forensic Sci Int (2002)126, 11-16.
